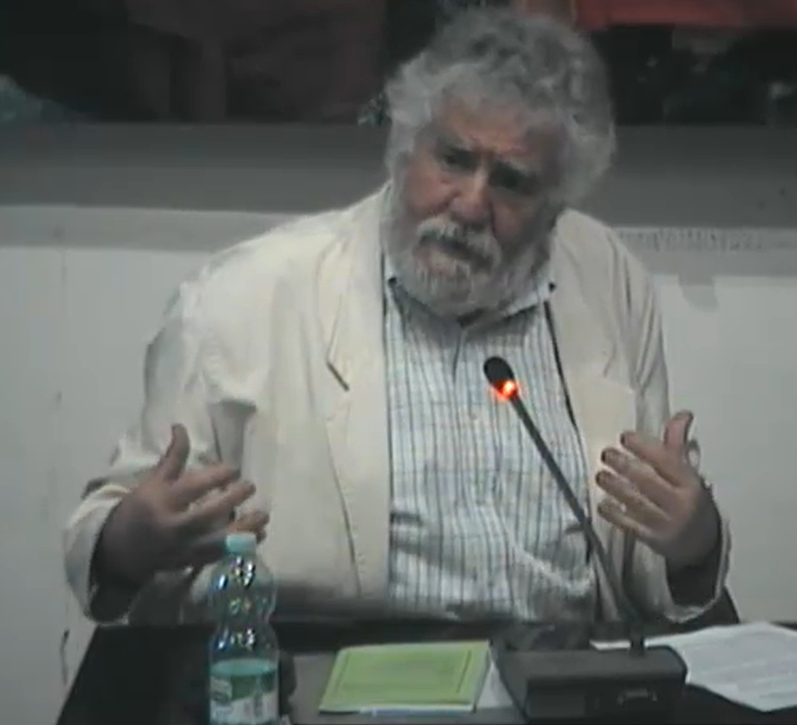Anche il XXV Congresso del Movimento Nonviolento si è svolto a Roma. Parliamo della primavera 2017. La serata di apertura è stata un dibattito condotto da Mao Valpiana con Daniele Lugli, il senatore Luigi Manconi e il disegnatore Mauro Biani. Riprendiamo da lì, grazie alla generosa registrazione di Radio Radicale, la prima parte dell’intervento di Daniele. Aveva da poco terminato l’incarico di Difensore civico della Regione Emilia-Romagna (2008-13) e il riflesso di quell’esperienza è evidente nel suo parlare.
Sulla legislazione italiana in materia di immigrazione già la Corte Costituzionale è intervenuta per ridimensionare quella sorta di diritto speciale che si veniva configurando, sul quale per esempio un costituzionalista di valore come Luigi Ferrajoli da tempo aveva insistito, o che l’amico giurista Andrea Pugiotto aveva brillantemente affrontato in un articolo intitolato “Purché se ne vadano”: ogni strumento è buono pur di liberarci di queste presenze; una posizione portata avanti con una ferita all’ordinamento che ci riguarda tutti quanti.
Vengono riproposti, con altro nome, i CIE, Centri di Identificazione e di Espulsione. Non è che cambiando il nome ne cambiamo la sostanza. Questi Centri hanno dimostrato abbondantemente il loro fallimento. La loro presenza è stato un altro fatto grave all’interno del nostro tessuto amministrativo e sociale, oltre che dal punto di vista giuridico.
Ho conosciuto l’esperienza del CIE di Bologna. Ci sono andato su invito di quello che allora era il responsabile, Daniele Giovanardi, fratello dell’onorevole Giovanardi. Mi ha chiamato nella qualità di Difensore civico dell’Emilia-Romagna e il suo invito mi è valso, perché ho avuto tante difficoltà a entrare al CIE, la prefettura non era d’accordo (io ci sono andato lo stesso). L’episodio da cui ha preso spunto l’invito riguardava un giovane tunisino che si era cucito con il fil di ferro le labbra. L’autolesionismo era diffuso all’interno di quel Centro, come spesso in carcere, di fronte a condizioni di segregazione assolutamente incivili e che ignorano i diritti umani.
In quella occasione, con i miei collaboratori, abbiamo visto come funziona un CIE. E dopo, naturalmente, abbiamo cercato di seguirne l’attività, anche grazie alla disponibilità che mi è stata data in quel momento da chi lo gestiva, sia pure con difficoltà. Con difficoltà ma anche con delle riflessioni, tant’è che lo stesso Giovanardi si era pronunciato, insieme alla Garante dei detenuti di Bologna, l’avvocata Desi Bruno, per il superamento del CIE, perché ne riscontrava quotidianamente l’incapacità di rispondere alle necessità per le quali era nato.
Un esempio solo. L’assistenza sanitaria non era affidata alla sanità pubblica. Andavano medici a contratto con il Ministero dell’Interno, avulsi dal sistema sanitario, per cui neanche si sapeva quali fossero le condizioni di salute di chi era all’interno. Avevi proprio la percezione di un’enclave. Il diritto si fermava alle sue porte, in tutti i suoi aspetti. E anche tra alcuni di questi medici che ho conosciuto, una delle espressioni più facili era: “Bisogna stare attenti perché i migranti sono come delle scimmie, si arrampicano dappertutto, cercano di scappare…”.
Questo era il modo di essere di un CIE. All’interno, degli operatori, e fuori dei soldati in armi che lo circondavano, più qualche gruppo di un centro sociale che ogni tanto cercava di entrare, quelli che erano dentro che davano fuoco ai materassi e dopo dormivano sul cemento…
Il CIE di Bologna ha finito la sua attività perché dopo l’ennesima gara al ribasso, come si faceva per assegnare la gestione, ha vinto un’associazione che non pagava gli operatori, non portava le vettovaglie che servivano, non rispettava le dotazioni necessarie, per cui il Centro è stato chiuso. E, nel CIE, quello che avveniva era questo: di tanto in tanto il Ministero avvisava il gestore: manda fuori venti persone perché te ne devo mandare altre venti. Che queste persone fossero state identificate o meno non aveva nessuna importanza, l’ordine era quello e veniva eseguito. Era un luogo di trattenimento secondo valutazioni del tutto esterne che non avevano logica. Riproporlo oggi, sulla base di quell’esperienza, è, credo, una cosa di assoluta inciviltà. L’esperienza ci dice che non può funzionare. Ma poi lo sappiamo tutti quanti, quando si vogliono dare risposte repressive ai problemi sociali, l’unica cosa che si fa è aggravarli.
Sappiamo e abbiamo capito che le concentrazioni sono una risposta sbagliata. Ho l’esperienza della mia città, dove i problemi ci sono, tutti quanti, e della mia provincia, dove non a caso in un piccolo comune, a Goro, si sono fatte le barricate per respingere una decina di donne di cui una incinta, perché erano “il pericolo dell’invasione”. Ma a livello diffuso le cose hanno funzionato e funzionano con una dimensione diversa, inversa, cioè la stragrande maggioranza dei Comuni accoglie, e la distribuzione tende ad avvenire attraverso una presenza di migranti sul territorio in appartamenti, in piccoli centri di accoglienza… se no è impossibile parlare di integrazione.
Ci sono anche altri aspetti che vanno considerati. Penso ai giovani che vengono da noi; beh, sono in età da servizio civile. In Italia abbiamo dichiarato che il servizio civile è universale, abbiamo detto che possono svolgerlo anche i cittadini stranieri regolarmente residenti. Allora, l’estensione del servizio civile ai richiedenti asilo, è una delle strade da seguire. Se si mette un giovane italiano a lavorare accanto a un coetaneo che viene da un altro Paese su una cosa di interesse comune, si sta già facendo concretamente un’azione di integrazione. Certo che va costruita, non ci arriva per proclazione. Io penso che questa, per il Movimento Nonviolento, sia una delle proposte che può e deve portare avanti, sapendo che, se questo fa, è possibile trovi Comuni, Regioni – non tutti – che intanto danno questo tipo di supporto e si vede se la cosa funziona.